
Epoca contemporanea
Negli anni ’60 la prima svolta: in una società sempre meno contadina e
sempre più cittadina, l’esigenza primaria è conservare. È il trionfo di
scatolette e tetrapak, pastorizzazione e sterilizzazione. Nell’era della
conquista del cosmo (la liofilizzazione è tra i brevetti delle ditte
spaziali) il cibo è scomposto nei suoi elementi primari, perde la sua
identità per diventare polvere o crema.
L’infatuazione per il sintetico ha breve durata e negli anni ’70 il
vero boom è il cibo confezionato pronto ad
essere stivato nel congelatore, a volte di grandi dimensioni. Inizia così
l’ascesa inarrestabile del surgelato, affermatosi negli Stati Uniti già
nel dopoguerra. Il fascino della lunga conservazione, abbinata ai sapori
immutati si rivela ben presto irresistibile. Merito del picco di freddo a
-20°C che garantisce spinaci anche d’inverno, e capretto fuori stagione.
Negli anni ’80 prevalgono nuovi valori: velocità e qualità, sensoriale
e nutrizionale. Agli ingredienti singoli si affiancano i piatti completi,
in nome della rapidità di preparazione e di consumo. Il frozen food
diventa fast food. Nel 1982 gli italiani consumano 203 mila tonnellate di
surgelati, nell’86 si sfiora quota 300 mila. Tra i nuovi protagonisti, gli
Iqf, Individually quick frozen, le porzioni per single che tamponano i
disastri sentimentali dei giovani rampanti, e gli stir fry, specialità
precotte pronte in tempi record, il meglio della cucina mondiale nel
congelatore.
Ma gli Anni ’80 sono anche quelli dei grandi scandali alimentari e la
corsa al risparmio di tempo e fatica deve fare i conti con una nuova
esigenza di sicurezza. L’attenzione si sposta su un tipo nuovo di fresco,
cui la tecnologia aggiunge rapidità di consumo (come nell’insalata
pretagliata) o valori sanitari. E al surgelato subentra la refrigerazione.
Intorno al ’95 trionfa un’ideologia che al transgenico oppone tipico e
biologico e con Slow food l’Italia riscopre il lato edonistico del
mettersi a tavola, con un occhio di riguardo alla salute. I prodotti bio e
tradizionali conquistano fette sempre più ampie di mercato.
Oggi per quasi tutte le categorie lavorative il pranzo è diventato una
pausa dal lavoro e non più pasto, il tempo del cibo non è produttivo per
cui va ridotto al minimo tant'è vero che spesso si continua a parlare di
lavoro anche a pranzo.
Le donne vivono parallelamente all'uomo i ritmi di lavoro, le nonne
sono una specie rarissima in via di estinzione, i ragazzi se piccoli,
mangiano nelle mense scolastiche e, se grandi, mangiano a casa da soli o
in compagnia nei fast-food; quindi la società dove il tempo è il parametro
più vistoso impone uno stile di vita alimentare che noi abbiamo lentamente
assimilato con spirito acritico.
Le dinamiche affettive, psicologiche legate al cibo cambiano, e la
figura femminile non è più l'angelo del focolare; la casa non è più
l'unico luogo dove si consuma il pasto quotidiano, dove qualcuno ha
lavorato per metterti a tavola. Il cambiamento radicale dello stile di
vita delle famiglie ha condotto quindi a squilibri nutrizionali non
indifferenti.
I giovani sono attirati dal fuori pasto (patatine, snack al
cioccolato, pizzette...); nel fuori pasto c'è il fascino dello stare
insieme ed anche di poter fare delle scelte autonome e diverse da quelle
della famiglia. Gli adolescenti mangiano volentieri cibi confezionati,
anche negli intervalli tra un pasto e l'altro e davanti alle televisione
dopo cena, non mangiano invece frutta, verdura, pesce e la prima colazione
è molto povera o addirittura assente.
Tutto si deve assimilare al comportamento del gruppo (vestiti, zaini,
letture, musica, cibo); questi aspetti nelle grandi città sono molto più
esasperati, però anche nelle piccole città di provincia serpeggia da parte
dei giovani una contestazione verso le abitudini alimentari tradizionali.
I mezzi di comunicazione, da parte loro, anticipano e propongono modelli
di comportamento alimentare sponsorizzati dall'industria alimentare, e i
consumi alimentari, grazie alla TV, si stanno appiattendo in modo veloce e
tragico.
Al functional food, il bio «sicuro» che fa bene alla salute, si è
affiancato il nutraceutical food, il «cibo arricchito» con vitamine o
altre sostanze, a metà tra il cibo e il farmaco, e spuntano cibi strani:
latte con Omega 3, pane agli isoflavoni della soia per le donne in
menopausa, succhi di frutta alle vitamine, sale con iodio, jogurt al
bifidum o, negli Usa, la mela conservata in estratto di vino rosso, con la
quantità di flavonoidi (utili contro i tumori) di 5 bicchieri di vino. In Italia si prevede una crescita del settore fino al 20% nei prossimi
anni.
"E' bene che la scienza si occupi dell'alimentazione - afferma lo chef
Davide Scabin, che a Rivoli, nel suo ristorante Combal Zero, propone
piatti futuristici come il cyberegg - ma la gastronomia è un piacere, non
un menù da ospedale. Con la nuova cucina molecolare, fisica e chimica
stanno cercando di imporsi ai fornelli: una deriva tecnologica che va
combattuta".
La tipicità e le sfaccettature
della cucina italiana hanno inciso sulla morfologia del territorio e anche
sulla creatività del popolo italiano: perdere questa ricchezza è un
rischio che non dobbiamo correre.
Proprio per salvaguardare il patrimonio della cultura
materiale del cibo, minacciato dalla standardizzazione indotta dal fast
food e riscoprire i sapori delle nostre tradizioni alimentari, da
assaporare in buona compagnia, è nato nel 1989 Slow Food, un Movimento
Internazionale a sostegno della cultura del cibo e del vino. Tra i suoi
obiettivi anche quelli di offrire, ai consumatori
golosi, informazioni sul mercato e strumenti
critici per imparare a scegliere il meglio al giusto prezzo e difendere
l'ambiente naturale dalle aggressioni dell'agricoltura chimica.
Sono stati istituiti veri e propri “laboratori del
gusto”, dove adulti e ragazzi guidati da degustatori professionisti
riscoprono la vasta gamma di fragranze e sapori che un cibo può offrire.
La maggior parte dei cibi scelti, ha sapori decisi, forti, aromi elaborati
per contrastare la tendenza dei giovani a preferire i sapori tenui, i cibi
di consistenza soffice: non essendo più abituati ai sapori, non li
conoscono, quindi li disdegnano.
Dopo quasi 15 anni di attività i soci di Slow Food sono oltre 70.000
sparsi per tutto il mondo: sedi nazionali sono state aperte in Germania,
Svizzera, Stati Uniti e, più di recente, a Barcellona.

E in futuro la mappa del genoma ci consentirà di nutrirci in
modo più adeguato o ridurrà ad un’operazione asettica uno
dei momenti più piacevoli
della nostra vita?
O saremo addirittura costretti a emigrare su altri
pianeti, vista la drammatica situazione ecologica del globo terrestre?
......?
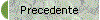 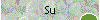 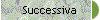

|