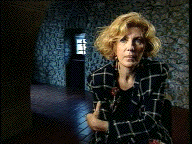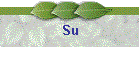|

"CODICE ’900", CHIAVE DI ACCESSO ALLA COMPLESSA REALTA’
CONTEMPORANEA
PREMESSA
La scelta di tale tematica è scaturita dalla volontà
di non delegare solo al manuale di Storia l’organizzazione delle
conoscenze sulla contemporaneità e di confutare l’idea diffusa che la
storia sia una stratificazione di fatti che procede sulla linea
ininterrotta del tempo fino ad un punto scelto.
Il tempo, come dice Braudel, non è un flusso continuo
e regolare, ma un intreccio di durate; una stratificazione complessa,
secondo Ensensberger, che la memoria e la storia attraversano
contemporaneamente producendo sempre situazioni nuove.
Allora il problema non è quello di aggiungere
argomenti nuovi ad un già lungo discorso, ma quello di esplorare, con
diversi livelli di profondità, presente , passato e futuro.
Non è un’impresa facile narrare il Novecento: le
sequenze frenetiche del nostro vivere quotidiano, in continua tensione tra
slanci mistici e predominio terreno, fra le metropoli funzionali della
civiltà tecnologica e le masse disorganizzate del terzo mondo , fra pace e
guerra, globalizzazione dei mercati e sfrenato individualismo.
Perché questo secolo sia compreso nella sua qualità
storica è necessario il filtro di categorie analitico-interpretative che
ne definiscano con chiarezza i contorni, i parametri di riferimento , la
trasmissione scientifica dei saperi.
L’analisi del Novecento esplora i diversi ambiti cognitivo-operativi
che lo hanno caratterizzato:
 |
scienza e tecnologia;
|
 |
guerre religiose e laiche che hanno coinvolto masse umane mai viste
nel passato;
|
 |
lotte tra democrazia e totalitarismo causa di vergognosi genocidi;
|
 |
trionfo dell’economia nelle versioni di capitalismo e di socialismo;
|
 |
affermazione della priorità del soggetto;
|
 |
sconcertante fecondità artistica e letteraria .
|
Non fabula storica, quindi, ma identificazione dei
fenomeni e loro integrazione secondo le regole della ricerca/azione.
Inoltre nella storia contemporanea c’è un fattore di
grossa rilevanza didattica perché gli studenti non osservano la storia
dall’esterno ma, consapevolmente o non, la vivono.
E’ spiegabile così perché non può essere delegata ad
un manuale l’organizzazione delle conoscenze sulla contemporaneità bensì
ad una serie di laboratori di ricerca-azione che meglio possono introdurre
l’alunno nelle molteplici realtà del Novecento.
FINALITA’ GENERALI
 |
Sviluppare negli alunni le capacità di cogliere nel
passato le proprie radici, valutare il presente, ricavare dati per
progettare il futuro.
|
OBIETTIVI TRASVERSALI
 |
Acquisire la capacità di trasferire un certo numero
di abilità anche al di fuori del campo di indagine preso in esame;
|
 |
Sviluppare le capacità di socializzazione con
l’assunzione di comportamenti intersoggettivi come il comprendere le
ragioni dell’altro o collaborare all’impostazione ed alla risoluzione di
problemi;
|
 |
Potenziare le capacità riflessive, con la
consapevolezza ed il confronto delle concettualizzazioni acquisite.
|
OBIETTIVI SPECIFICI
 |
Saper individuare gli elementi essenziali di un evento, cioè di quei
fatti e quei fenomeni che hanno provocato all’interno di una realtà
politica, economica, sociale, culturale cambiamenti ed effetti
significativi;
|
 |
saper collocare un fatto o un fenomeno in un contesto di rapporti
temporali, spaziali e causali;
|
 |
saper distinguere i diversi aspetti politici, sociali e culturali di
un evento;
|
 |
saper cogliere l’interazione delle componenti di un evento;
|
 |
saper padroneggiare linguaggi e strumenti di lavoro specifici perché
non conta tanto sapere quanto compiere operazioni e processi mentali
efficaci.
|
ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’
 |
organizzazione dei docenti per aree omogenee e programmazione delle
fasi del lavoro di sperimentazione;
|
 |
attività di sperimentazione attuata in orario curricolare ed
extracurricolare;
|
 |
socializzazione dell’iniziativa con apertura ai genitori ed al
territorio attraverso documentazione e pubblicazione di materiale
documentale.
|
ORGANIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Il progetto ha previsto il raggruppamento delle discipline per aree
omogenee come appresso indicate:
 |
AREA LINGUISTICA: lingua italiana e straniera.
|
 |
AREA STORICO-SCIENTIFICA: Scienze fisiche, chimiche e naturali;
Storia; Geografia.
|
 |
AREA LOGICO - OPERATIVA ED INFORMATICA: Matematica, Ed.Tecnica.
|
 |
AREA ESTETICO-ESPRESSIVA: Ed.Artistica, Ed.Musicale, Ed.Fisica.
|
METODOLOGIE DELLA RICERCA E DELLA COMUNICAZIONE
 |
AREA 1 : tecniche di destrutturazione,
contestualizzazione e modificazione dei messaggi per l’acquisizione di
abilità finalizzate alla produzione di testi;
|
 |
AREA2 : metodo induttivo, astrazione concettuale su
base sperimentale;
|
 |
AREA 3: lavoro di gruppo, attività di analisi e di
sintesi, problem-solving; tecniche multimediali di produzione;
|
 |
AREA 4: destrutturazione dei codici linguistici di
comunicazione.
|
STRATEGIE DIDATTICHE
 |
Guide di osservazione, analisi degli errori, prove
diagnostiche,colloqui,ecc.;
|
 |
Uso di modelli, classificazioni, teorie di
riferimento e griglie, per favorire il passaggio dalla complessità dei
contenuti alla riduzione concettuale degli stessi;
|
 |
Attenzione ai rapporti fra soggetti, oggetti,
contesti;
|
 |
Analisi testuale;
|
 |
Metodo comparativo delle fonti;
|
 |
Uso di carte e grafici spaziali, temporali, sociali;
|
VALUTAZIONE
L’allievo ha bisogno di un docente che gli faccia da
guida e lo affianchi nei suoi processi di apprendimento, che sia un
attento regista delle attività didattiche, disposto ad utilizzare in modo
promozionale lo strumento della valutazione:
 |
diagnostica, sia come rilevazione della situazione
di partenza, sia come verifica dei processi di apprendimento, sia nella
relazione educativa;
|
 |
formativa, come momento intermedio di controllo
sistematico dei processi di apprendimento e di sviluppo personale;
|
 |
sommativa, come bilancio complessivo del livello di
maturazione dell’alunno, descritto attraverso prove oggettive, saggi,
prove orali.
|
CONDIZIONI ORGANIZZATIVE
Tempi
Ottobre: programmazione dei curricoli di apprendimento
da parte dei docenti;
Novembre/Maggio: attività di ricerca-azione in orario
curricolare, laboratori di produzione in orario extracurricolare.
Classi interessate
31 classi per un totale di 803 alunni + 4 corsi
sperimentali per adulti per un totale di 118 alunni.
Spazi e strutture
aule scolastiche, auditorium, laboratorio di
informatica,etc.
Il lavoro si è concluso con una
drammatizzazione sulla vita di Gaetano Di Biasio e una mostra
alla cui inaugurazione sono intervenuti l'abate di Montecassino Mons.
Bernardo D'Onorio, le autorità, i genitori.
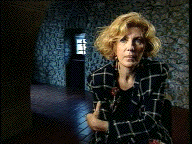
Invitata speciale la scrittrice Eva Cantarella |